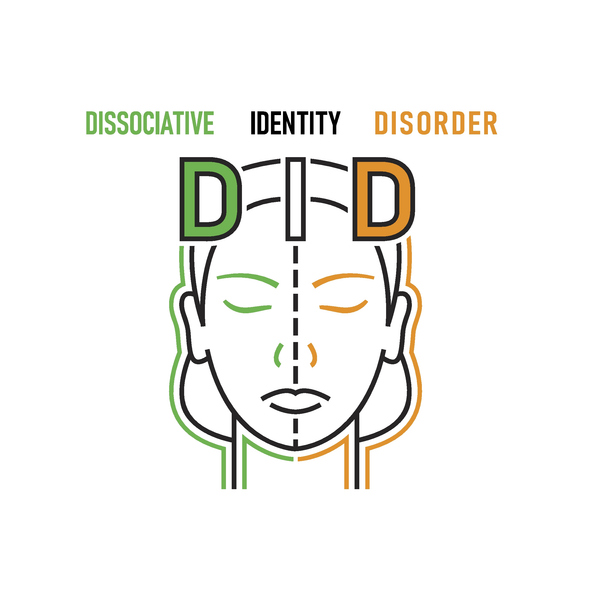
A volte, quando la realtà diventa troppo dura da affrontare, la mente si protegge. Non lo fa sempre in modo evidente, né secondo logiche razionali. Lo fa come può, nel modo che le è più familiare: ci allontana. Dal dolore, dall’esperienza che stiamo vivendo, talvolta persino da noi stessi. Questo meccanismo si chiama dissociazione e può sembrare, a chi non lo ha mai sperimentato, qualcosa di strano o estraneo. In realtà, è uno dei modi più profondi e antichi che l’essere umano ha sviluppato per sopravvivere a ciò che è emotivamente insostenibile. La dissociazione, nella sua forma più lieve, è comune e perfettamente normale. Quasi tutti, ad esempio, abbiamo vissuto momenti in cui “stacchiamo” mentalmente: ci distraiamo durante un lungo viaggio in auto, sogniamo a occhi aperti durante una riunione, perdiamo per un attimo la consapevolezza del presente. Ma in alcune persone, soprattutto in coloro che hanno vissuto traumi gravi o ripetuti – come abusi, violenze, perdite traumatiche – questo meccanismo di difesa diventa cronico. Si trasforma in un’interruzione profonda e duratura della continuità della coscienza, dando origine a quella che viene definita come una classe specifica di disturbi: i disturbi dissociativi. Quando la dissociazione non è più un evento passeggero, ma una condizione ricorrente che interferisce con la vita quotidiana, con la memoria, con la percezione del sé o del mondo esterno, si entra in un campo complesso ma fondamentale della salute mentale. Comprendere cosa sono i disturbi dissociativi significa entrare in contatto con il potere della mente di proteggersi, ma anche con il dolore profondo che questi meccanismi cercano di contenere. Significa riconoscere, senza giudizio, che anche la frammentazione può essere un tentativo – disperato, ma umano – di tenere insieme ciò che altrimenti sarebbe insopportabile.
Cosa sono i disturbi dissociativi
I disturbi dissociativi sono condizioni psicologiche che implicano una disconnessione tra elementi fondamentali dell’esperienza umana: pensieri, emozioni, ricordi, sensazioni, identità. È come se il filo che normalmente tiene insieme il nostro senso del sé si spezzasse in più puti, lasciandoci confusi, smarriti o distaccati dalla realtà. In queste condizioni, la dissociazione non è più un fenomeno momentaneo, ma un pattern cronico. Le persone che ne soffrono possono percepire sè stesse come osservatrici esterne della propria vita, oppure sperimentare amnesie per interi periodi della loro storia. Altre ancora raccontano di vivere in un mondo che appare irreale, ovattato, come dentro un sogno. In tutti i casi, ciò che viene meno è il senso di continuità della coscienza. La dissociazione, in questi casi, non è una scelta né una forma di debolezza. È, al contrario, il segno di una mente che ha dovuto trovare un modo per andare avanti di fronte a traumi che avrebbero potuto frantumare l’integrità psichica. Spesso, dietro un disturbo dissociativo si nasconde una storia personale difficile, fatta di abusi, negligenze affettive, perdite precoci, esperienze destabilizzanti vissute in età in cui non si avevano ancora le risorse per elaborarle.
Il disturbo dissociativo dell’identità
Tra i disturbi dissociativi, quello che ha ricevuto maggiore attenzione – spesso in modo sensazionalistico – è il disturbo dissociativo dell’identità, noto in passato come disturbo da personalità multipla. Chi vive con questa condizione manifesta due o più identità distinte che si alternano nel controllo del comportamento. Ogni identità ha caratteristiche proprie: un modo diverso di parlare, di muoversi, di percepire il mondo. Alcune identità possono avere memorie che le altre non condividono, generando confusione, amnesie, senso di disorientamento. Il DID, come viene abbreviato, non è una finzione cinematografica né un’esagerazione clinica. È il risultato di un meccanismo di sopravvivenza estremo, quasi sempre radicato in traumi infantili severi e prolungati. Per affrontare un dolore continuo e inelaborabile, la mente suddivide l’identità in “parti” che possono affrontare specifici aspetti dell’esperienza, proteggendo l’insieme dal collasso emotivo. Non si tratta di “essere qualcun altro”, ma di esistere in molteplici configurazioni del sé, ognuna con una funzione protettiva.
Amnesia dissociativa
L’amnesia dissociativa è una condizione in cui la persona perde l’accesso a ricordi importanti della propria vita, in particolare quelli legati a eventi traumatici. Non si tratta di una dimenticanza comune, ma di una vera e propria lacuna nella memoria, che può riguardare ore, giorni, anni o addirittura tutta la propria storia personale. Questa perdita può essere localizzata – riferita a un solo episodio – oppure più estesa, e in alcuni casi può assumere la forma di “fuga dissociativa”: la persona si allontana fisicamente dal proprio ambiente, spesso assumendo una nuova identità, senza ricordare nulla della propria precedente vita. È un meccanismo di protezione estremo, in cui la mente “cancella” ciò che non riesce a integrare. Anche se la memoria può talvolta tornare spontaneamente, le conseguenze emotive e pratiche di queste amnesie possono essere molto destabilizzanti.
Depersonalizzazione e derealizzazione
La depersonalizzazione è una forma di distacco interiore. Chi la vive racconta di sentirsi come fuori dal proprio corpo, di osservare sé stesso dall’esterno, come se fosse un attore che recita in un film. La derealizzazione, invece, riguarda la percezione dell’ambiente: le cose sembrano irreali, alterate, lontane. In entrambi i casi, la persona mantiene la consapevolezza che si tratta di una percezione alterata, e proprio questo rende l’esperienza ancora più angosciante. Queste forme dissociative, pur non compromettendo il contatto con la realtà come avviene nei disturbi psicotici, possono comunque interferire in modo significativo con la vita quotidiana. Chi ne soffre spesso si sente isolato, incompreso, e fatica a spiegare agli altri ciò che sta vivendo. Anche questi disturbi sono frequentemente legati a esperienze traumatiche e possono comparire in concomitanza con ansia, panico, stress post-traumatico o depressione.
Cause e diagnosi: un puzzle da ricomporre con delicatezza
Le radici dei disturbi dissociativi affondano quasi sempre in un terreno segnato da traumi. L’infanzia è una fase particolarmente delicata: quando un bambino sperimenta eventi altamente stressanti senza un adulto che possa aiutarlo a elaborare ciò che accade, la mente può attivare meccanismi dissociativi per proteggere l’integrità psichica in formazione. Ma anche traumi in età adulta, stress acuti o condizioni di vita opprimenti possono innescare o riattivare la dissociazione. Diagnosticare un disturbo dissociativo richiede tempo, sensibilità clinica e una formazione specifica. Spesso chi ne soffre arriva alla diagnosi dopo anni di sofferenza e diagnosi parziali. Il percorso passa attraverso colloqui approfonditi, l’uso di strumenti psicodiagnostici e l’ascolto attento della storia di vita del paziente. Nessuna macchina può restituire una risposta automatica: serve una relazione umana, terapeutica, basata sulla fiducia e sulla comprensione profonda della sofferenza.
Trattamento e possibilità di guarigione
La psicoterapia è il trattamento principale per i disturbi dissociativi. In particolare, le terapie orientate al trauma, come l’EMDR o la terapia sensomotoria, si sono dimostrate efficaci nel ridurre i sintomi e favorire l’integrazione dell’esperienza traumatica. L’obiettivo non è “cancellare” le parti dissociate, ma accompagnare la persona a riconnettersi con sé stessa in modo sicuro, graduale, rispettoso dei suoi tempi. In alcuni casi, possono essere utili farmaci per gestire sintomi associati, come l’ansia o la depressione, ma non esistono farmaci specifici per la dissociazione. La buona notizia è che la guarigione è possibile. Il processo può essere lungo, complesso, fatto di fasi e ricadute, ma con il giusto supporto professionale e relazionale, molte persone riescono a ritrovare una continuità interna, un senso di identità più stabile, una vita piena di significato.
Ricomporsi è possibile
La dissociazione è la lingua silenziosa del trauma. È il modo in cui la mente prova a salvarsi quando la realtà diventa insopportabile. Ma ciò che un tempo è servito per sopravvivere può, col tempo, diventare una prigione interiore. Comprendere i disturbi dissociativi significa riconoscere questo paradosso: che ciò che ci ha protetti può anche isolarci, e che per guarire serve imparare a reintegrare, a ricucire, a ricomporsi. Non si tratta solo di eliminare i sintomi, ma di ritrovare la strada verso sé stessi. E questo cammino, per quanto faticoso, è profondamente umano. La dissociazione non è follia. È una forma estrema di intelligenza del corpo e della psiche. Ma nessuno dovrebbe affrontarla da solo. E nessuno è oltre la possibilità di cura.

Silvia Trevaini
VideoNews


